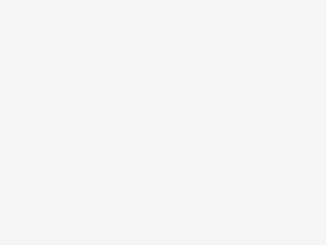Dietro ai fornelli di un ristorante, grande o piccolo che sia, c'è un mondo che non ti aspetti mentre gusti la tua cena. Ed è fatto spesso di cuochi che lavorano in nero, di aiutanti sottopagati, di personale addetto al lavaggio, straniero e senza alcuna tutela. Lo ha raccontato con tanti particolari, anche difficili da digerire, Leonardo Lucarelli nel numero di gennaio-marzo del bel trimestrale Il Reportage, attraverso la storia di un cuoco precario 35enne che ha cucinato nei ristoranti di mezza Italia ma ha trovato ovunque la stessa condizione di sfruttamento. Riportiamo la sua testimonianza.
"Ho 35 anni e da 12 faccio il cuoco. La mattina mi alzo, saluto la mia compagna che inizia a lavorare alle otto, faccio qualche commissione e alle nove vado al ristorante. Mi metto la divisa nera con il nome ricamato in rosso, scherzo con i colleghi, prendo un caffè e guardo la lista delle prenotazioni, dei banchetti e dei fornitori, prima di iniziare a cucinare. Faccio pausa dalle 15 alle 18, quando inizio il secondo turno, che dura di solito fino alle 22. A volte finisco più tardi. Lavoro in un albergo in provincia di Vicenza. In cucina siamo in quattro più due lavapiatti: Eduardo, ventenne romeno e Joseph nigeriano di 35 anni arrivato in Italia via mare dalla Libia durante l’insurrezione anti-Gheddafi. In sala si alternano in cinque, altre due ragazze romene lavorano al bar, in tre puliscono le camere, due sono alla reception e altre due al centro benessere. Fernando, da solo, si occupa delle pulizie notturne e di preparare le colazioni, di giorno dorme in una delle stanze dell’albergo e, in pratica, vive sempre qui dentro. A fine mese prendo 850 euro di stipendio, più altri mille euro in nero. Ho un contratto part-time di quarto livello, a termine. E come me, con diverse proporzioni, sono pagati i miei colleghi. Le proporzioni si giocano sulla quantità di nero, la busta paga è uguale per tutti. A me piace questa professione fatta di cibo, vini, tradizione e innovazione. Mi piace leggere di cucina, informarmi, e ultimamente è abbastanza facile, c’è internet, decine di riviste dedicate e almeno una rubrica di cucina praticamente su ogni rivista. Ma non mi capita mai di leggere il racconto di come funzioni un’industria che occupa centinaia di migliaia di lavoratori e che è strutturata intorno al lavoro sommerso, non denunciato, non garantito e non tassato.
La mia è la storia di un qualsiasi cuoco italiano discretamente capace. Dietro le porte dell’eccellenza ci sono cucine nelle quali si nasconde lo sfruttamento degli immigrati, l’utilizzo fraudolento ed elusivo dei contratti di collaborazione, di lavoro discontinuo e di associazione in partecipazione, dove i soldi neri veri non sono quelli che si giocano nel rapporto locale-cliente (anche perché la merce si deve fatturare per forza, e una volta fatturata occorre dimostrare che la si vende), ma quelli tra locale-dipendenti. La caccia allo scontrino di cui si legge in questi mesi è poco coerente con la realtà dell’occupazione grigia della ristorazione, che sembra difficile da controllare solo perché la struttura delle regole relative al lavoro nei locali permette una parvenza di regolarità, che diventa prassi dell’evasione.
Cifre nere – I dati ufficiali parlano di una composizione del lavoro nero in Italia (secondo l’Istat, tra i 255 e i 275 miliardi di euro) in cui la quantità di persone contrattualizzate in maniera atipica sta avendo un peso sempre maggiore, in particolare nella ristorazione, dove le fasi lavorative e le nicchie con bassa produttività permettono modalità contrattuali che rendono più facile eludere le regole. I dipendenti risultano regolarizzati ma in realtà hanno mansioni e orari enormemente maggiori rispetto a quanto denunciato.
Nel febbraio 2011 la commissione per la riforma fiscale che si occupa di economia non osservata e flussi finanziari, ha reso note le elaborazioni dell’Istat che entrano nel dettaglio rispetto ai dati del sommerso diffusi per macrosettori nel luglio 2010. Il quadro è disarmante, il Pil sommerso in Italia si attesta tra un minimo del 16,1 e un massimo del 17,8 per cento dell’economia reale: il valore più alto si registra, appunto, nel settore della ristorazione e pubblici esercizi che, con il 56,8 per cento, supera quello del settore agricolo (31,1), dell’edilizia (28,4), del commercio (21,7 per cento) e perfino quello di domestici e badanti, fermo al 52,9 per cento.
Lavoro da 12 anni in cucine di alto livello e la totalità delle aziende in cui sono stato impiegato sfrutta almeno il 50 per cento del monte ore necessario a mandare avanti l’attività senza regolarizzarle. Ho prestato servizio in 14 diversi locali, due di questi stellati, a Roma sono stato chef di quattro ristoranti, ho lavorato a Firenze, a Siena, nel Mugello, a Porto Rotondo, a Ferrara, a Bassano del Grappa e ad Asiago. In nessuna di queste 14 aziende sono mai stato assunto in regola. La stella Michelin, poi, al contrario di quanto si potrebbe pensare, diventa motivo per alzare l’asticella dello sfruttamento: i contratti sono gli stessi, ma le ore aumentano e diminuisce il fuori busta perché “fa curriculum”. La genialità dei migliori chef sta nel poter disporre di manodopera a bassissimo costo, illegale, e quindi di una cucina in cui dieci persone si occupano di 35 coperti.
Alla fine del 2011 mi sono trasferito in Veneto per seguire la mia compagna che era stata assunta in questa regione virtuosa del lavoro. Sono arrivato senza conoscere nessuno, con un buon curriculum sotto braccio ma una gavetta da cominciare praticamente da capo. Il mio primo colloquio l’ho fatto a Bassano del Grappa, la Silicon Valley del Nord Italia, dove mi è stato proposto un contratto come cuoco di quarto livello da 30 ore settimanali e 900 euro mensili. A queste andavano aggiunte altre 40 ore, in nero, con una integrazione fuori busta di 600 euro. Significa lavorare 310 ore al mese (più vari straordinari non riconosciuti) a meno di 5 euro l’ora. Tale accordo lavorativo, a titolo di assunzione, mi è stato offerto dopo due mesi di “prova” totalmente in nero. Gavetta, appunto. In cucina c’erano altri quattro cuochi con il medesimo trattamento. Il sous-chef aveva il mio stesso contratto, 1.100 euro fuori busta e molte responsabilità in più (organizzazione delle forniture, gestione dei turni e dei menù straordinari, rapporto con la sala). Sofia, la lavapiatti nigeriana, era assunta con contratto a chiamata, 15 ore al mese segnate per lavorarne oltre 200. In sala giravano molti camerieri, alcuni totalmente in nero, la maggior parte con contratto a chiamata, tre erano assunti part-time, tutti prendevano dai 400 ai 700 euro in nero al mese. Lo chef era il proprietario. In un ristorante che il sabato sera fa oltre 200 coperti risultano lavorare cinque cuochi di quarto livello (quindi senza responsabilità diretta e senza capacità attestata di assumersela) con contratto part-time, tre camerieri part-time e altri 3-4 a chiamata presenti per meno di 20 ore mensili, una sola lavapiatti presente, non in nero, per sole 15 ore mensili. La realtà è fatta di almeno ottomila euro di stipendi pagati in nero ogni mese, di circa 1.200 ore “fantasma” di lavoro a settimana e di persone che hanno una responsabilità effettiva che non risulta da nessuna parte.
Ora vivo ancora in Veneto, ma ci siamo trasferiti più a nord, ad Asiago. In aprile sono stato assunto in un Hotel 4 stelle lusso, contratto part-time di 2 mesi, le solite 30 ore settimanali, ma quinto livello (il minimo per avere accesso in cucina), per circa 800 euro mensili. In realtà faccio dalle 48 alle 56 ore settimanali e sono capopartita dei secondi, cioè gestisco autonomamente tutta l’inerenza diretta alla lavorazione della carne e del pesce. Le ore di straordinario, per fortuna, mi vengono pagate (in nero) e a fine mese mi metto in tasca altri 1.000 euro consegnati a mano in una busta bianca senza intestazione. Tre dei camerieri lavorano come extra totalmente in nero e tutti gli altri (chef compreso) percepiscono un fuori busta a fine mese.
Non è una situazione straordinaria, non è “la crisi”. La situazione più paradossale, forse, l’ho vissuta a Ferrara, dove siamo rimasti circa un anno, dopo Roma e prima del trasferimento in Veneto. Là ho trovato quasi subito lavoro in un ristorantino di nuova apertura in pieno centro storico. Il posto era piccolino, circa 25 coperti: qui sono stato chef e unico cuoco per circa sei mesi. Non erano previsti giorni di riposo, si lavorava sette giorni su sette, pranzo e cena. La mia posizione contributiva prevedeva un contratto a chiamata in cui figuravano dalle 15 alle massimo 25 ore mensili di servizio, il mio stipendio (2.000 euro) era completamente in nero. Come può un ristorante non subire nessun controllo se è aperto sempre e serve tutti i clienti con un solo cuoco che lavora massimo 20 ore al mese? C’è un disavanzo di 280 ore mensili. Forse perché il posto era piccolo, semisconosciuto, mi dico. Ma com’è possibile, invece, che ristoranti illuminati dalla Stella Michelin, possano avere fino a 2 o 3 “stagisti” che lavorano gratis, immigrati irregolari che stanno fino a 12 ore in cucina per 30 euro e nessun contratto registrato per mansioni oltre il part-time di quarto livello?
Nell’ultimo ristorante in cui ho lavorato a Roma, una Stella Michelin, 12 persone in cucina per servire circa 40 clienti ogni sera, c’erano due stagisti (la legge prevede che non si possa avere più di uno stagista alla volta), uno completamente gratis, l’altro, 20 anni, percepiva 500 euro mensili, in nero. Nessuno degli assunti in cucina superava il 4° livello e Miguel (detto Miky), originario di Manila, aveva un contratto a chiamata per giustificare la sua presenza quotidiana alla lavastoviglie. Per me solito contratto, retribuzione effettiva di 1.300 euro, circa 12 ore di servizio al giorno per sei giorni a settimana.
Siamo tutti cuochi di quarto livello e camerieri part-time, tutti eterni ragazzini che fanno lavoretti per mantenere gli studi. Tre anni fa alla conclusione dell’ennesimo contratto a termine (le dimissioni nel nostro ambiente si danno così, si va dal proprietario e si chiede di non rinnovare il contratto, almeno si può accedere alla disoccupazione) sono andato all’Inps per chiedere il sussidio, scoprendo che dopo 12 anni passati in cucina risultano poco più di tre anni di contributi versatimi. Queste modalità di trattamento dei dipendenti è stato enormemente agevolato dalla Legge Biagi del 2003, che introducendo il contratto a chiamata ha fatto sì che le cifre regolarizzate diminuissero considerevolmente a fronte delle stesse ore di impiego e dello stesso trattamento economico. Perché a dispetto delle buone intenzioni (regolarizzare chi, di fatto, lavorava solo per poche ore a settimana) mancano gli adeguati strumenti di controllo.
Il contratto a qualunque costo – Nel biennio 2010-2011 la quota di ristoranti che ha assunto personale immigrato è stata quasi doppia rispetto alla quota media delle aziende di tutti gli altri comparti. Il motivo è semplice. Con la regolarizzazione di colf e badanti del 2010, la maggior parte dei clandestini ha sborsato di tasca propria le spese necessarie alla documentazione e al pagamento del forfait per i contributi pregressi, spesso pagando anche l’italiano che si è prestato a dichiarare di usufruire dei loro servizi in casa, mentendo. Tutto questo per poter essere poi assunti presso il ristorante in cui già lavoravano da anni completamente in nero. In alcuni casi lo stipendio percepito dopo la regolarizzazione è anche diminuito, perché se al proprietario conviene rischiare meno e registrare un contratto che giustifichi la presenza del lavoratore in caso di controllo, non vuole però addossarsi le spese aggiuntive dei contributi.
All’epoca, nel ristorante romano in cui ero chef, al lavaggio c’era Mohassim, detto Mox, un bengalese clandestino di 52 anni, pagato 750 euro al mese in nero. Siamo diventati amici, io e Mox, e spesso dopo il lavoro lo accompagnavo a casa in moto, evitandogli le due ore di bus a cui era abituato per raggiungere l’appartamento di 70 metri quadrati in cui viveva nella periferia Est di Roma con altre undici persone. Me li ricordo bene i suoi occhi lucidi quando ha saputo che il miraggio del permesso di soggiorno era a portata di mano, costava 1.500 euro, non sarebbe più stato “invisibile” e lo avrebbero assunto al ristorante con un contratto regolare, finalmente. Lo stavano sfruttando, gli stavano chiedendo dei soldi che avrebbero dovuto pagare le persone che avevano usato il suo lavoro per anni, lo avrebbero sfruttato ancor di più pagandolo di meno e tenendolo sotto scacco con lo spauracchio della perdita del contratto, ma lui era felice mentre mi chiedeva in prestito quel denaro che non aveva. È stato assunto, infatti, part-time, 20 ore settimanali per 600 euro mensili. In realtà di ore ne faceva 60, ma per lui il fuori busta non era contemplato. Semplicemente lavorava circa 260 ore al mese con 150 euro al mese in meno di prima.
Da dicembre ho un nuovo lavoro da chef in Trentino. Questa volta sono riuscito a strappare un contratto di terzo livello da 1.200 euro al mese, più un fuori busta di mille euro: lavorerò sei giorni a settimana pranzo e cena. Durante l’alta stagione invernale invece farò l’intera settimana. Il proprietario godrà dei benefici che la regione autonoma mette a disposizione per chi dà inizio a una nuova attività nel settore alberghiero.
Quando andate a cena fuori, o a far colazione, o a bere un aperitivo, guardatevi intorno e chiedetevi quanto e come sono pagate le persone che vi servono e quanto la quantità di evasione sistematica va a pesare sui sacrifici che lo Stato vi chiede in tempi di crisi".
foto di Jacopo Cossater, www.enoicheillusioni.com